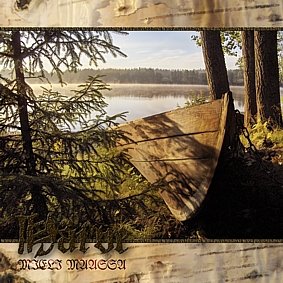|
| Season Of Mist, 2010 |
Dopo la pubblicazione dell'intenso ed esaltante "Microcosmos", una vera ventata di aria fresca per chi dava i Drudkh spacciati dopo i contestati "Anti - Urban" ed "Estrangement", ecco che arriva il nono album in studio, puntuale come un orologio e prodotto sempre dalla Season Of Mist, a rimescolare ancora una volta le carte in tavola e a mostrare un volto differente della band ucraina, un terreno che ancora non era stato battuto. Ciò non ha ovviamente mancato di procurare al gruppo diverse critiche, ma come al solito i fan si sono divisi in due gruppi: chi apprezza il nuovo corso della band nonostante tutto, e chi invece lo ripudia andando a rimpiangere i primi, stupendi lavori degli ucraini. Da che parte stare, vi chiederete voi?
C'è da dire che, una volta terminata la breve introduzione pianistica, un brano come "Downfall Of The Epoch" lascia perlomeno perplesso chi era abituato ad ascoltare i Drudkh di "Forgotten Legends". Il suono si è abbondantemente ripulito, la produzione è diventata cristallina e quasi patinata, le sonorità hanno abbandonato quasi del tutto i terreni atmospheric - pagan black e si sono orientate decisamente più verso il post - rock, e perfino verso un certo tipo di doom, quello che per intenderci ha reso famosi i Katatonia. Impossibile non trovare similitudini con dischi come "Dance Of December Souls" e "Brave Murder Day", partendo dall'uso delle chitarre per arrivare alle ritmiche altamente ripetitive e quasi ipnotiche, nè veloci nè lente, senza tralasciare ovviamente l'uso di atmosfere un po' depresse e sicuramente più tranquille rispetto alle oniriche e burrascose composizioni degli esordi. Perfino la voce, che prima era un aspro scream che si incastrava tra gli strumenti in modo grezzo e approssimativo (e per questo tremendamente efficace), ora è diventata più preponderante e protagonista della scena, quasi come se volesse scavalcare gli strumenti, e ha perso un po' della sua carica selvaggia, acquisendo maggiore controllo e impostazione (per quanto sempre di scream si tratti). Le composizioni sono molto più lineari e quadrate, il riffing si è ulteriormente semplificato ed è difficile che rimanga qualcosa impresso nella mente, data l'omogeneità del tutto; potremmo quasi dire che il sound si è banalizzato, ma ciò è vero solo in parte.
"Handful Of Stars", infatti, nonostante la sua estrema semplicità e il suo abbandono verso le sonorità più ruvide ed evocative, non è per niente un brutto disco. Non mi faccio remore a dire che sicuramente è il prodotto meno interessante della discografia della band, escludendo ovviamente lo scialbo EP "Anti - Urban"; eppure, le capacità del gruppo ormai consolidate fanno sì che anche un disco non particolarmente ispirato come questo risulti piacevole e ben costruito. Sicuramente i brani sono un po' troppo uguali a sè stessi e anche tra di loro, nonostante nella seconda metà del disco vi sia un parziale ritorno alle origini (nel senso che compaiono sonorità leggermente più aggressive sia dal punto di vista vocale sia strumentale); è vero anche che qui il gruppo pesca abbondantemente dai Katatonia e da molte altre band venute almeno un decennio prima; ed è vero che non si sente più molto il legame con la natura e con le forze nascoste del cosmo, insomma quello spirito panteistico che ha sempre caratterizzato la musica della band. Ma qualcosa rimane sempre, un qualcosa che sotto sotto emoziona e coinvolge: una sottile malinconia, una pacata rassegnazione che tuttavia cela una venatura di rabbia, una gentile rivisitazione dei propri stati d'animo che si esprime attraverso cavalcate strumentali di pregevole fattura (prendete per esempio "Towards The Light", con i suoi interessanti chiaroscuri). Forse il tentativo di variare il sound è stato sfruttato male, nel senso che si poteva fare di più per rendere il disco maggiormente dinamico e variato; ma ripeto, non riesco a considerarlo un brutto album. Forse è semplicemente un'occasione mancata, un disco che avrebbe potuto essere molto di più e invece si ritrova ad essere solo un discreto esperimento, piacevole ma non memorabile.
"Handful Of Stars" è un disco che formalmente non ha nulla di sbagliato: in certi momenti riesce ad essere emozionante e a far viaggiare l'immaginazione, anche se ormai i tempi d'oro della band sono lontani e i primi dischi sono storia. Risente forse di un'eccessiva artificiosità della produzione, di strutture un po' trite e ritrite e di una certa staticità compositiva, ma tutto sommato si lascia ascoltare. Un piacevole accompagnamento per un viaggio in macchina, o per un momento di tranquilla meditazione sdraiati sul letto; non aspettatevi che immagini poderose vengano alla vostra mente, ma aspettatevi comunque quaranta minuti di onesta musica. Per i fan del gruppo, non mi sento di esprimere alcun parere: decideranno loro se considerare "Handful Of Stars" come una piacevole variazione sul tema oppure come una sbandata evitabile. Per quanto mi riguarda, scelgo la prima ipotesi.
01 - Cold Landscapes (1:14)
02 - Downfall Of The Epoch (12:10)
03 - Towards The Light (9:18)
04 - Twilight Aureola (9:00)
05 - The Day Will Come (9:06)
06 - Listening To The Silence (1:04)