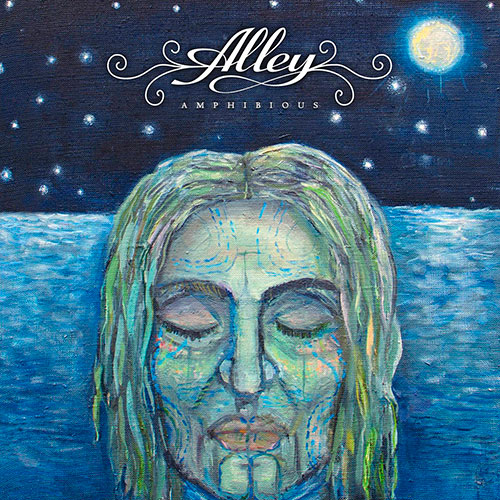|
| Autoprodotto, 2013 |
Talvolta, la ricerca di nuove scoperte musicali passa attraverso territori improbabili: si scovano incredibili sorprese tra le band più sconosciute dell'universo underground finlandese, o russo, o cileno, o di qualsiasi altra nazione stramba che si possa immaginare. Quanto più la provenienza di tali band è inconsueta e lontana, tanto più il prodotto viene accolto con entusiasmo, anche perchè spesso si scoprono orizzonti musicali dei quali mai si sarebbe sospettata l'esistenza. Fin qui è tutto abbastanza scontato, ma ciò che non è scontato è il fatto che a volte non serve andare tanto lontano per trovare delle vere e proprie band rivelazione: a volte arrivano da casa propria, l'ultimo posto da dove ci si sarebbe aspettati una sorpresa simile. Un ottimo esempio di ciò sono i rEarth, band udinese di cinque elementi che approda con questo "For My Dreams I Fall" al proprio primo traguardo discografico ufficiale, completamente autoprodotto così come fu fabbricato in proprio il loro primo demo, risalente a due anni addietro.
Immaginate i primi Pain Of Salvation, quelli che ancora suonavano con quella drammaticità e quella sensazione di pulsante disagio che traspariva da ogni singola nota; aggiungete loro una consistente venatura thrash metal, influenze derivanti dai migliori cantautori italiani e dalle loro poesie su note di chitarra acustica, e completate il quadro con l'uso pressoché costante di doppia voce (maschile e femminile) e con una composizione intricata e imprevedibile: riuscite a immaginare questo cocktail messo in musica? Perfetto, ma sappiate che ciò serve solo a farvi un'idea generale di come suonino i rEarth, perchè la loro musica è fin troppo complessa e variegata per essere descritta in poche parole. Potrebbe però essere sufficiente per incuriosirvi, così come mi sono incuriosito io quando ascoltai il loro demo "Pure And Simple", che qui compare riprodotto per intero e posizionato in coda al disco, non come mera appendice bensì come parte conclusiva e integrante del contesto. Il disco si sviluppa come un concept album che tratta temi difficili, spinosi: la guerra, la sofferenza, la condizione umana e le sue molteplici sfaccettature: i testi sono intrisi di parole forti, spesso urticanti, talvolta volgari, nessuno spazio viene lasciato alla piacevolezza fine a sé stessa.
Il disco si sviluppa in un'ora e un quarto di durata, mettendo tantissima carne al fuoco, con una tale ricerca di poliedricità e una quantità di materiale così vasta da lasciare inizialmente disorientati. Il potenziale di questo disco è impossibile da cogliere tutto al primo ascolto: la prima traccia "Pain For Loss (Pain No More)" sembra che l'avrebbe potuta suonare una qualsiasi band thrash metal, con l'unica differenza che per una volta canta anche in italiano e non solo in inglese (i testi sono in doppia lingua, alternati tra una e l'altra), ma questa congettura derivante da un primo ascolto superficiale si dimostra inadeguata. Dietro le ritmiche aggressive, i suoni secchi e la voce graffiante, infatti, si nasconde un intero mondo di ricerca compositiva, melodica e tecnica da far impressione, se si considera la giovane età della band. Sbalorditiva è la capacità tecnica dei musicisti coinvolti, con le chitarre di Fabio Tomasino e Edy Di Lenardo che si danno battaglia senza esclusione di colpi, rotolando furiosamente su sè stesse e una attorno all'altra, mentre la sezione ritmica a cura del bassista Denis Baselli e del batterista Giulio Cervi gioca su controtempi spezzati e continui stop and go che definire esaltanti è dire poco. Ma la vera particolarità è data dalla voce di Simone Paoloni, che pare dotato di quattro o cinque voci diverse, da usare a seconda dei contesti. Con il proseguire del disco, sia gli strumenti sia la voce si lasciano infatti andare a mille sfumature diverse, esplorando lidi progressive e suggestioni jazz - rock, pestando duro con riff assassini e ritmiche violente per poi lanciarsi in lunghe soffusioni acustiche che tavolta paiono accompagnare una recitazione (in questo si sente moltissimo l'influenza di musicisti come De Andrè): come se la musica fosse l'accompagnamento di una vera e propria storia da raccontare, diversamente da ciò che succede di solito, con i testi che vengono considerati come un abbellimento della musica. I brani sono spaventosamente complessi, sempre in cambiamento: quasi mai si assiste a un ritornello o ad una struttura facilmente inquadrabile, la fantasia della composizione è a livelli imbarazzanti (in senso positivo!) e l'ascolto assomiglia più a una complessa esperienza di scoperta, più che alla semplice fruizione di belle melodie e fraseggi appassionati. La voce di Paoloni sa interpretare gli stati d'animo più disparati, come si evince già dalla successiva "Withered Rose", più tranquilla e melodiosa, con una voce che diventa quasi melliflua, prima di esplodere di nuovo in una rabbia cavernosa che poi lascia nuovamente posto ad una tensione espressa sottovoce, ma palpabile. Quasi impossibile stare dietro a tutte le evoluzioni che si contano in questi sette minuti. Il vero capolavoro arriva poi con "Senz'Alba", monumentale composizione di dodici minuti che esplora le emozioni umane nel modo più onnicomprensivo possibile. Assieme alla leggiadra voce di Sara Rainone, capace di sottolineare i momenti più dolci e lacrimevoli con una naturalezza spettacolare, l'interpretazione che Paoloni riesce a dare di questo lungo e drammatico brano è incredibile, un manifesto di quanto possa essere complesso l'animo dell'uomo e sopratutto di come possa essere vasto il dolore che un uomo possa provare (da brividi il verso clou: "Ricordati che nel mio giardino è morto un bambino"). Anche solo a livello tecnico / timbrico, si tratta di una delle voci più particolari e mutevoli che io abbia mai sentito, non a caso paragonabile all'ecletticità di Daniel Gildenlow, leader dei Pain Of Salvation. Ma lungi da me il pensare che i rEarth scimmiottino la band svedese: sarebbe un'eresia sostenere una cosa del genere. Se c'è una cosa che non manca ai rEarth, questa è di sicuro la personalità e l'originalità.
Nel proseguire del disco, centinaia di mood e di passaggi musicali di sapori diversi inondano la scena senza mai essere fuori posto, regalando momenti di emozionalità pura così come di pensosa riflessione, così come di rabbia incontenibile e di amarezza per la vita. "Ivory Onion" giunge a donare un po' di pace con i suoi due minuti e mezzo di chitarra acustica dal fortissimo sapore folk: un intermezzo che pare raccontare le antiche storie dei nostri nonni, raccontate davanti al fuoco durante le gelide serate di dicembre. Inizia allo stesso modo "My Eyes Far From The Sea", dove però si rifanno sentire le influenze thrash, con la voce di Paoloni che si ingrossa e si arrabbia sempre più fino a sfiorare addirittura il growl, e che si perde poi nuovamente in cascate di note acustiche dal piglio apparentemente scherzoso. Altri titoli evocativi come "Madre Del Fato", "Breath, The End..." e "The Ideology Of God" nascondono altre incalcolabili successioni di stati d'animo e di trame strumentali che non riesco nemmeno a definire, tanto sono inclassificabili nelle loro evoluzioni. Virtuosismo, mai fine a sè stesso, virtuosismo nel vero senso della parola: tecnica e ricerca della complessità al servizio della musica e dei sentimenti. Questa è la musica dei rEarth, un eccezionale risultato di genialità e ispirazione, un disco che si potrebbe ascoltare per vent'anni senza riuscire a capirlo, ma non per inadeguatezza del disco, quanto per inadeguatezza dell'ascoltatore. Sono consapevole che questa descrizione potrà apparire un po' forzata e pomposa, ma se non mi credete, potrete sempre tuffarvi nel mondo dei rEarth e scoprire che non ho esagerato per nulla nelle mie affermazioni. Il fatto che sia stato concepito da menti italiane è un ulteriore plauso, perchè per troppo tempo la musica italiana (e in particolare il metal italiano) è stato ingiustamente vituperato e irriso. Mi chiedo se la band stessa sia consapevole del fatto di aver partorito un vero capolavoro.
Il disco si conclude con la riproposizione della lunga suite "Pure And Simple", divisa in cinque parti e dedicata al tema della crescita personale: è il momento che continuo a ritenere come il migliore del disco, e non solo perché è l'unico che conoscevo già. In questi ultimi venti minuti si condensa tutto il meglio dei rEarth, tutta la bellezza che sono in grado di scrivere sul pentagramma come se fosse la cosa più naturale del mondo, tutta la passione che mettono nella musica e negli strumenti. Ma mi trovo davvero in difficoltà con le parole, non so più da che parte iniziare a descrivere la musica, quindi getto le armi: ho parlato abbastanza. Se vorrete acquistare "For My Dreams And Fall", sappiate che vi attende un'esperienza musicale meravigliosa, senza precedenti. C'è un'intera vita, qui dentro: chi vuole viverla, si procuri questo album senza ulteriori indugi!
01 - Pain For Loss (Pain No More) (2:53)
02 - Withered Rose (7:13)
03 - Senz'Alba (12:00)
04 - Ivory Onion I (2:36)
05 - My Eyes Far From The Sea (9:01)
06 - Madre Del Fato (10:34)
07 - Breath, The End... (3:15)
08 - The Ideology Of God (3:39)
09 - Pure And Simple - Theme I - No Longer A Child (4:31)
10 - Pure And Simple - Theme II - To My Faded Innocence (8:12)
11 - Pure And Simple - Theme III - In The Shadow, In The Sand, You Can See The Man (3:04)
12 - Pure And Simple - Theme IV - Become Man, Becoming Death (2:41)
13 - Pure And Simple - Theme V - Here She Comes, Pure And Simple (2:39)