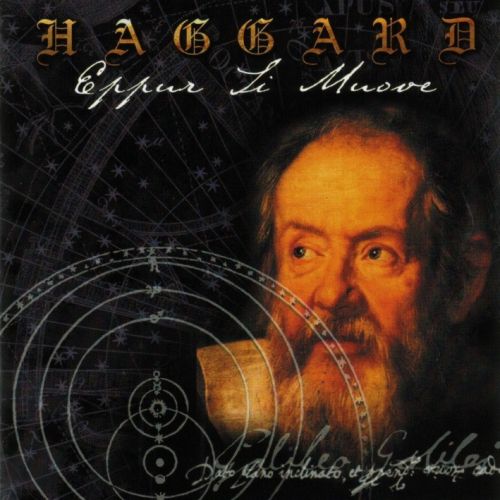|
| Thrill Jockey Records, 2011 |
Tinte piatte, tre colori. Due croci nere antagoniste inchiodate su di uno sterminato mare di bianco puro. Scritte dorate nel più semplice dei font. Una copertina di tali minimalismo e audacia non può fare a meno di catturare la mia attenzione, specie se la band che vi sta dietro sono i Liturgy, che si erano fatti notare solo due anni prima col loro ottimo Renihilation.
Si scopre a posteriori che quella sgargiante copertina è profetica: Aesthethica è una sorta di catarsi del Black Metal, un album la cui copertina per converso è “white” e racchiude il “black” unicamente nei due crocifissi, una sorta di sua trasposizione verso il trascendente, la sua ascesa verso le sfere dell’Avantgarde e del Post. Non a caso la band definisce la propria musica come Trascendental Black Metal. Per la verità qui di Black nel vero senso della parola non c’è molto al contrario di quanto fu Renihilation, e se non fosse per il cantato in uno scream quasi Depressive tipico di Hunter Hunt-Hendrix probabilmente saremmo qui a parlare di Math/Avantgarde. Aesthethica è infatti un matrimonio tra geometria e irrazionalità, tra regolarità e impeto spontaneo: riff spigolosi e regolari si susseguono con un’attitudine Math degna dei Meshuggah, talvolta ripetuti fino a sfiorare la nausea, ma al tempo stesso con ritmiche selvagge e scomposte e con un cantato animalesco. La geometria impeccabile disegnata dalle chitarre, il logos, viene meno sotto i colpi del pathos che ne distorce le rette, ne ammacca le circonferenze e ne sfonda i piani; e dagli squarci che questo ruvido marasma generale incide nella liscia corazza della razionalità zampillano potenti getti di impetuosa melodia carica di irrefrenabile sentimento che pervade ogni brano. Come detto, Aesthethica è un matrimonio tra geometria e irrazionalità, forse anche in virtù del fatto che le idee sulla trascendenza sono figlie di madre ragione, la quale però non può arrivare a comprenderle, cioè non può arrivare ad abbracciare le sue creazioni, i suoi stessi figli: da qui l’annichilente dualità che permea tutto l’album.
Mi pare di cogliere nella musica dei Liturgy anche una certa tendenza alla scomposizione degli elementi musicali, piuttosto che alla loro fusione come invece sempre più spesso avviene oggi. Infatti in Aesthethica c’è di più dello straripante Avantgarde Black Metal descritto sopra, molto di più: tra i suoi fendenti si ritaglia la propria nicchia un brulicante microcosmo fatto di brevi strumentazioni estemporanee e inclassificabili, quasi fossero un corpo estraneo venuto da chissà dove, eppure così familiari e accoglienti. Ne sono degli ottimi esempi la cibernetica Helix Skull o la superba prestazione vocale che costituisce Glass Earth - anche se fin troppo monotona nelle sue fasi iniziali... -, per non parlare delle intro dei primi tre brani. A fianco di questo microcosmo va aggiunto il macrocosmo dell’impronta Math esplicita di Generation e dello scultoreo Sludge di Veins Of God, due eccellenti ordinati episodi che si distinguono nettamente dal chaos che li circonda. Ma il fatto di rilievo è, come dicevo, che tutto questi “universi nell’universo” di Aesthethica non si mescolano col resto della musica, tendono a rimanerne separati, disgiunti, coesistono l’uno accanto all’altro come tante sub-entità funzionalmente distinte di un unico Uno universale. Se nel mondo odierno del Metal sussiste una tendenza a levigare sempre più le disparate influenze musicali che infarciscono le proprie creazioni, fino a renderle un tutt’uno perfettamente amalgamato, Aesthethica appare invece come un diamante grossolanamente tagliato che alterna facce grosse a facce molto piccole, ognuna delle quali ben distinta per perimetro e inclinazione da tutte le altre. Ho anche provato ad immaginarmi quali vette vertiginose potrebbe raggiungere la band se solo cercasse di fondere tra loro queste sue diverse qualità, ma nonostante tale fantasticheria sia dannatamente intrigante ciò significa fare violenza sul’artista, su ciò che i Liturgy sono e vogliono essere: come tali vanno accolti o respinti, senza cercare di plasmarli a proprio piacimento. Se proprio si deve parlare dei lati negativi di questo disco reputo più costruttivo citare il fatto che gli splendidi riff Old School Black Metal che rendevano così irresistibile il debutto Renihilation sono qui completamente scomparsi, e questo a mio avviso è un vero peccato. Ma forse in fondo anche questo non è altro che un segno della catarsi di cui i Liturgy ci cantano...
E così si afferma un’altra band che farà molto parlare di sé, nel bene e nel male, band che dopo solo due album ha già letteralmente spaccato in due le opinioni degli appassionati: c’è chi li ritiene mostruosi e chi vede in Aesthethica un gigantesco flop. Personalmente non posso non ritenermi soddisfatto di aver acquistato e ascoltato fino allo sfinimento questo singolarissimo disco, e in tutta franchezza esso mi invoglia tremendamente a seguire i risvolti futuri della band: sono proprio curioso di vedere quale direzione imboccheranno Hunter Hunt-Hendrix e soci per dar seguito a quanto di notevole sono riusciti a fare finora.
01 - High Gold (05:16)
02 - True Will (05:27)
03 - Returner (03:35)
04 - Generation (07:07)
05 - Tragic Laurel (04:05)
06 - Sun Of Light (06:55)
07 - Helix Skull (02:32)
08 - Glory Bronze (06:45)
09 - Veins Of God (07:55)
10 - Red Crown (07:23)
11 - Glass Earth (03:28)
12 - Harmonia (05:28)
Si scopre a posteriori che quella sgargiante copertina è profetica: Aesthethica è una sorta di catarsi del Black Metal, un album la cui copertina per converso è “white” e racchiude il “black” unicamente nei due crocifissi, una sorta di sua trasposizione verso il trascendente, la sua ascesa verso le sfere dell’Avantgarde e del Post. Non a caso la band definisce la propria musica come Trascendental Black Metal. Per la verità qui di Black nel vero senso della parola non c’è molto al contrario di quanto fu Renihilation, e se non fosse per il cantato in uno scream quasi Depressive tipico di Hunter Hunt-Hendrix probabilmente saremmo qui a parlare di Math/Avantgarde. Aesthethica è infatti un matrimonio tra geometria e irrazionalità, tra regolarità e impeto spontaneo: riff spigolosi e regolari si susseguono con un’attitudine Math degna dei Meshuggah, talvolta ripetuti fino a sfiorare la nausea, ma al tempo stesso con ritmiche selvagge e scomposte e con un cantato animalesco. La geometria impeccabile disegnata dalle chitarre, il logos, viene meno sotto i colpi del pathos che ne distorce le rette, ne ammacca le circonferenze e ne sfonda i piani; e dagli squarci che questo ruvido marasma generale incide nella liscia corazza della razionalità zampillano potenti getti di impetuosa melodia carica di irrefrenabile sentimento che pervade ogni brano. Come detto, Aesthethica è un matrimonio tra geometria e irrazionalità, forse anche in virtù del fatto che le idee sulla trascendenza sono figlie di madre ragione, la quale però non può arrivare a comprenderle, cioè non può arrivare ad abbracciare le sue creazioni, i suoi stessi figli: da qui l’annichilente dualità che permea tutto l’album.
Mi pare di cogliere nella musica dei Liturgy anche una certa tendenza alla scomposizione degli elementi musicali, piuttosto che alla loro fusione come invece sempre più spesso avviene oggi. Infatti in Aesthethica c’è di più dello straripante Avantgarde Black Metal descritto sopra, molto di più: tra i suoi fendenti si ritaglia la propria nicchia un brulicante microcosmo fatto di brevi strumentazioni estemporanee e inclassificabili, quasi fossero un corpo estraneo venuto da chissà dove, eppure così familiari e accoglienti. Ne sono degli ottimi esempi la cibernetica Helix Skull o la superba prestazione vocale che costituisce Glass Earth - anche se fin troppo monotona nelle sue fasi iniziali... -, per non parlare delle intro dei primi tre brani. A fianco di questo microcosmo va aggiunto il macrocosmo dell’impronta Math esplicita di Generation e dello scultoreo Sludge di Veins Of God, due eccellenti ordinati episodi che si distinguono nettamente dal chaos che li circonda. Ma il fatto di rilievo è, come dicevo, che tutto questi “universi nell’universo” di Aesthethica non si mescolano col resto della musica, tendono a rimanerne separati, disgiunti, coesistono l’uno accanto all’altro come tante sub-entità funzionalmente distinte di un unico Uno universale. Se nel mondo odierno del Metal sussiste una tendenza a levigare sempre più le disparate influenze musicali che infarciscono le proprie creazioni, fino a renderle un tutt’uno perfettamente amalgamato, Aesthethica appare invece come un diamante grossolanamente tagliato che alterna facce grosse a facce molto piccole, ognuna delle quali ben distinta per perimetro e inclinazione da tutte le altre. Ho anche provato ad immaginarmi quali vette vertiginose potrebbe raggiungere la band se solo cercasse di fondere tra loro queste sue diverse qualità, ma nonostante tale fantasticheria sia dannatamente intrigante ciò significa fare violenza sul’artista, su ciò che i Liturgy sono e vogliono essere: come tali vanno accolti o respinti, senza cercare di plasmarli a proprio piacimento. Se proprio si deve parlare dei lati negativi di questo disco reputo più costruttivo citare il fatto che gli splendidi riff Old School Black Metal che rendevano così irresistibile il debutto Renihilation sono qui completamente scomparsi, e questo a mio avviso è un vero peccato. Ma forse in fondo anche questo non è altro che un segno della catarsi di cui i Liturgy ci cantano...
E così si afferma un’altra band che farà molto parlare di sé, nel bene e nel male, band che dopo solo due album ha già letteralmente spaccato in due le opinioni degli appassionati: c’è chi li ritiene mostruosi e chi vede in Aesthethica un gigantesco flop. Personalmente non posso non ritenermi soddisfatto di aver acquistato e ascoltato fino allo sfinimento questo singolarissimo disco, e in tutta franchezza esso mi invoglia tremendamente a seguire i risvolti futuri della band: sono proprio curioso di vedere quale direzione imboccheranno Hunter Hunt-Hendrix e soci per dar seguito a quanto di notevole sono riusciti a fare finora.
01 - High Gold (05:16)
02 - True Will (05:27)
03 - Returner (03:35)
04 - Generation (07:07)
05 - Tragic Laurel (04:05)
06 - Sun Of Light (06:55)
07 - Helix Skull (02:32)
08 - Glory Bronze (06:45)
09 - Veins Of God (07:55)
10 - Red Crown (07:23)
11 - Glass Earth (03:28)
12 - Harmonia (05:28)