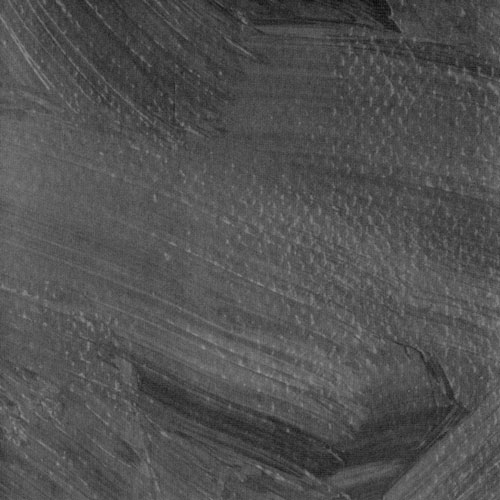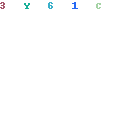|
| InsideOut Music, 2001 |
Sempre in bilico tra power e progressive metal e capitanati dall'intensa voce roca di Tom Englund, gli Evergrey sono una della realtà più interessanti nel loro ambito. Costantemente impegnati a mostrare come il power metal non sia solamente un ammasso di gruppi clone in crisi di idee, i cinque svedesi sono da sempre dediti a tematiche oscure e sinistre: "In Search Of Truth", infatti, contiene una marcata vena "dark" che gli dona una buona longevità, evitando di farlo scadere in una collezione di facili melodie da classifica che si dimenticano il giorno dopo.
La storia di questo concept è quella di un uomo che "sente le voci" e non si sente più al sicuro da nessuna parte, poiché è convinto di essere spiato da entità aliene. L'atmosfera di paranoia è evidente sia nel testo sia nella musica, che è potente e maestosa, debitrice degli stilemi del power ma anche piacevolmente contaminata dal progressive metal e dall'AOR (a volte sembra di sentire echi dei Royal Hunt). La voce di Tom è una delle migliori che si possano trovare nel genere: potente e ricca di espressività, è il meglio che si potrebbe chiedere per una musica del genere. L'uso delle orchestrazioni, ben calibrato e dosato quando serve, aumenta ancora di più la tensione che prosegue a mano a mano che il disco procede. La veloce "The Masterplan", ottima opener dal ritmo sincopato e dal refrain trascinante, porta alla più cadenzata e indiavolata "Rulers Of The Mind", nella quale l'apparente addolcimento della voce di Englund nel ritornello è solo un inganno: la seguente "Watching The Skies", probabilmente il pezzo migliore del disco, è quanto mai apocalittica e sinistra, in cui i suoni bassi si fanno di una profondità insospettabile per un gruppo power. I ritmi si fanno sempre più spezzati e sincopati, le chitarre suonano pesanti dissonanze; la tensione, altissima lungo tutto il brano in perfetto stile Evergrey, impedisce i cali di attenzione, facendo arrivare al finale col fiato sospeso. Una tregua ci è offerta con la malinconica "State Of Paralysis", breve intermezzo di pianoforte e voce, per poi ritornare a fare sul serio con "The Encounter" e "Mark Of The Triangle", i brani più metallici del lotto. "Dark Waters" è un altro episodio magistrale, che in una struttura semplice unisce azzeccatissimi arrangiamenti pianistici (che in questo album compaiono spesso) e una progressione melodica davvero accattivante, stavolta pienamente power metal. L'amara e disperata "Different Worlds", nella quale Englund fornisce la sua miglior prova vocale, è ancora una volta dominata da un pianoforte, cristalino e pulito, ma nel finale una chitarra stupendamente potente fa riprendere quota al brano, consegnandoci un pezzo d'intensità disarmante.
Il disco è chiuso da "Misled", brano che, ahimè, poteva essere costruito meglio: erano andati bene fino ad ora, e la parte strumentale del suddetto brano è molto interessante, ma il ritornello è davvero scontato. Peccato. Tuttavia, non facciamo gli schizzinosi: questo è un ottimo album e una leggera caduta di tono non sarà sufficiente per affossarlo. Peccato che con gli ultimi album i nostri Evergrey siano scaduti nella banale formula commerciale, seppur orecchiabile: ma ciò nulla toglie agli album di ottimo valore, come questo, dati alla luce in passato.
La storia di questo concept è quella di un uomo che "sente le voci" e non si sente più al sicuro da nessuna parte, poiché è convinto di essere spiato da entità aliene. L'atmosfera di paranoia è evidente sia nel testo sia nella musica, che è potente e maestosa, debitrice degli stilemi del power ma anche piacevolmente contaminata dal progressive metal e dall'AOR (a volte sembra di sentire echi dei Royal Hunt). La voce di Tom è una delle migliori che si possano trovare nel genere: potente e ricca di espressività, è il meglio che si potrebbe chiedere per una musica del genere. L'uso delle orchestrazioni, ben calibrato e dosato quando serve, aumenta ancora di più la tensione che prosegue a mano a mano che il disco procede. La veloce "The Masterplan", ottima opener dal ritmo sincopato e dal refrain trascinante, porta alla più cadenzata e indiavolata "Rulers Of The Mind", nella quale l'apparente addolcimento della voce di Englund nel ritornello è solo un inganno: la seguente "Watching The Skies", probabilmente il pezzo migliore del disco, è quanto mai apocalittica e sinistra, in cui i suoni bassi si fanno di una profondità insospettabile per un gruppo power. I ritmi si fanno sempre più spezzati e sincopati, le chitarre suonano pesanti dissonanze; la tensione, altissima lungo tutto il brano in perfetto stile Evergrey, impedisce i cali di attenzione, facendo arrivare al finale col fiato sospeso. Una tregua ci è offerta con la malinconica "State Of Paralysis", breve intermezzo di pianoforte e voce, per poi ritornare a fare sul serio con "The Encounter" e "Mark Of The Triangle", i brani più metallici del lotto. "Dark Waters" è un altro episodio magistrale, che in una struttura semplice unisce azzeccatissimi arrangiamenti pianistici (che in questo album compaiono spesso) e una progressione melodica davvero accattivante, stavolta pienamente power metal. L'amara e disperata "Different Worlds", nella quale Englund fornisce la sua miglior prova vocale, è ancora una volta dominata da un pianoforte, cristalino e pulito, ma nel finale una chitarra stupendamente potente fa riprendere quota al brano, consegnandoci un pezzo d'intensità disarmante.
Il disco è chiuso da "Misled", brano che, ahimè, poteva essere costruito meglio: erano andati bene fino ad ora, e la parte strumentale del suddetto brano è molto interessante, ma il ritornello è davvero scontato. Peccato. Tuttavia, non facciamo gli schizzinosi: questo è un ottimo album e una leggera caduta di tono non sarà sufficiente per affossarlo. Peccato che con gli ultimi album i nostri Evergrey siano scaduti nella banale formula commerciale, seppur orecchiabile: ma ciò nulla toglie agli album di ottimo valore, come questo, dati alla luce in passato.
01 - The Masterplan (4:46)
02 - Rulers Of The Mind (5:57)
03 - Watching The Skies (6:16)
04 - State Of Paralysis (2:13)
05 - The Encounter (4:38)
06 - Mark Of The Triangle (6:22)
07 - Dark Waters (6:02)
08 - Different Worlds (5:29)
09 - Misled (5:59)