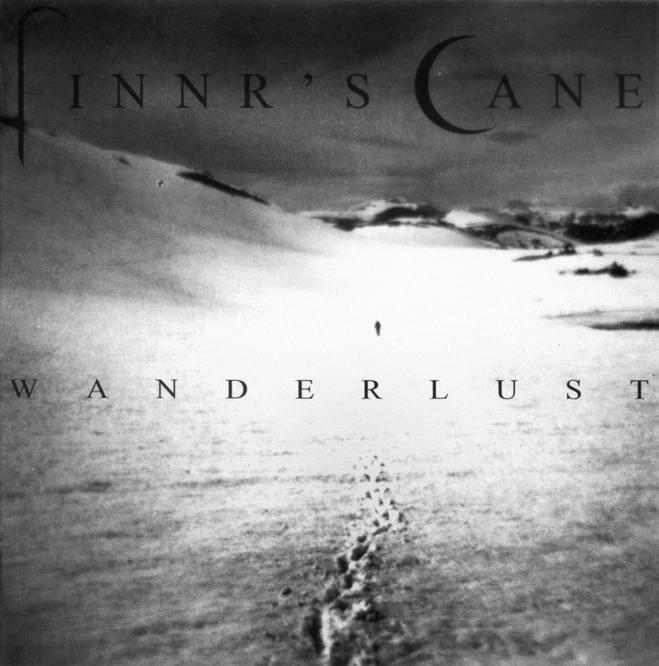|
| BadMoodMan, 2008 |
“Sarà la solita band Doom/Death, uguale a tutte le altre”. Questa è la prima cosa che viene in mente rimirando le pagine sfocate, la cromia marmorea e il logo materico ma poetico che compaiono sulla copertina di The Weed degli Alley. Sapendo poi che la band è russa e che è sotto contratto con la Solitude Productions non rimane alcun dubbio. Quando però il CD viene fatto partire si scopre invece che la Russia ha iniziato a sperimentare la clonazione umana: ci si ritrova infatti dinnanzi alla perfetta copia sovietica degli Opeth.
Qui non si tratta di semplice ispirazione, si tratta di imitazione a tutti gli effetti: le chitarre sono identiche, sia come sonorità che come tipo di riff; le ritmiche sono molto simili; le strutture dei brani sono progressive e mutevoli; di tanto in tanto compaiono i classici respiri in chitarra acustica; la voce poi è impressionante: il growl è pressoché identico, e il clean è così aderente all’originale che se solo Mikael Akerfeldt fosse più famoso il cantante degli Alley potrebbe vincere dei premi come imitatore. In altre parole, quando ascolterete The Weed vi sembrerà di essere davanti ad un ipotetico nuovo album degli Opeth. Non rimane che dedicarvi al famoso giochino: trova le differenze! Personalmente qualcuna l’ho individuata: posso segnalare un uso leggermente maggiore della grancassa, così come posso segnalare l’effimera tastiera verso metà di Fading Fall - ma come potete vedere per trovare delle differenze ci si deve proprio impegnare, quindi passo a voi il testimone.
Ma allora cosa si deve pensare di questi Alley? Cosa si deve pensare di questo loro disco d’esordio, tale The Weed? Voglio approfittare di questa situazione favorevole per esprimere qualche importante concetto sul copiare l’altrui arte. Moltissime recensioni dei più disparati album e provenienti dai più disparati siti non perdono occasione di puntare il dito contro la derivatività di certa musica, nonché contro le imitazioni che non cercano di proporre alcunché di nuovo, additandole come superflue e prive di contenuto comunicativo. Ora, finché si sostiene che molto difficilmente un album copiato da altri potrà essere un capolavoro mi trovo d’accordo. Ma il punto centrale della questione è: si vive di soli capolavori? Io credo proprio di no. E se è vero che un disco copiato difficilmente può essere un capolavoro, è altrettanto difficile che esso possa risultare piacevole? No, non lo è. Poi è vero, non ogni disco copiato è piacevole...ma questo degli Alley lo è: la musica proposta è ben lungi dall’essere banale, il songwriting è ampiamente sopra la media e riserva qualche passaggio davvero mozzafiato, il riffing è pregevole e l’esecuzione strumentale è ammirevole. Inoltre bisogna intercalarsi nella psicologia di chi suona: comporre un album musicale deve consistere necessariamente in una snervante ricerca di qualcosa di nuovo e originale? Oppure si possono comporre album musicali per puro divertimento? Io credo che questi quattro ragazzi russi siano dei fan sinceri degli Opeth e che di conseguenza trovino divertente ed eccitante imitare i loro inarrivabili idoli. Provate a proiettare su voi stessi la medesima situazione: non vi piacerebbe essere capaci di fare ciò che fanno le persone che più stimate? Non provereste soddisfazione nel realizzare di essere capaci di farle a vostra volta? Certo che sì. E poi in fondo per qualche nostalgico affezionato non è poi un male che ogni tanto spuntino band siffatte, visto che ultimamente gli Opeth - quelli veri - sembrano aver definitivamente abbandonato quel loro Progressive Death autunnale e paludoso che tanto li aveva resi celebri.
In definitiva io credo che ci siano cose ben più gravi da condannare che non le pacifiche scopiazzate, come ad esempio quelle band da quattro soldi quali Nightwish, Anathema, Amorphis ed altre che producono una musica così banale e commerciale che chiamarla musica è quasi un insulto, e lo fanno al solo fine della notorietà, dell’emancipazione dall’underground, dei dindi sonanti, svuotando così l’arte musicale di ogni significato artistico. Ecco, sono queste le band da stroncare brutalmente senza nemmeno il più piccolo briciolo di pietà, non certo gli appassionati musicisti come gli Alley che suonano quello che realmente gli appartiene, che gli scorre nelle vene, e che oltretutto in album come The Weed riescono a farlo in modo piacevole e convincente.
01 - Duhkha (04:44)
02 - Coldness (05:58)
03 - Dust Layer (09:11)
04 - Hessian Of Rime (07:21)
05 - Fading Fall (10:23)
06 - Jaded Mirrored (11:21)
07 - Days For Gray (14:35)
Qui non si tratta di semplice ispirazione, si tratta di imitazione a tutti gli effetti: le chitarre sono identiche, sia come sonorità che come tipo di riff; le ritmiche sono molto simili; le strutture dei brani sono progressive e mutevoli; di tanto in tanto compaiono i classici respiri in chitarra acustica; la voce poi è impressionante: il growl è pressoché identico, e il clean è così aderente all’originale che se solo Mikael Akerfeldt fosse più famoso il cantante degli Alley potrebbe vincere dei premi come imitatore. In altre parole, quando ascolterete The Weed vi sembrerà di essere davanti ad un ipotetico nuovo album degli Opeth. Non rimane che dedicarvi al famoso giochino: trova le differenze! Personalmente qualcuna l’ho individuata: posso segnalare un uso leggermente maggiore della grancassa, così come posso segnalare l’effimera tastiera verso metà di Fading Fall - ma come potete vedere per trovare delle differenze ci si deve proprio impegnare, quindi passo a voi il testimone.
Ma allora cosa si deve pensare di questi Alley? Cosa si deve pensare di questo loro disco d’esordio, tale The Weed? Voglio approfittare di questa situazione favorevole per esprimere qualche importante concetto sul copiare l’altrui arte. Moltissime recensioni dei più disparati album e provenienti dai più disparati siti non perdono occasione di puntare il dito contro la derivatività di certa musica, nonché contro le imitazioni che non cercano di proporre alcunché di nuovo, additandole come superflue e prive di contenuto comunicativo. Ora, finché si sostiene che molto difficilmente un album copiato da altri potrà essere un capolavoro mi trovo d’accordo. Ma il punto centrale della questione è: si vive di soli capolavori? Io credo proprio di no. E se è vero che un disco copiato difficilmente può essere un capolavoro, è altrettanto difficile che esso possa risultare piacevole? No, non lo è. Poi è vero, non ogni disco copiato è piacevole...ma questo degli Alley lo è: la musica proposta è ben lungi dall’essere banale, il songwriting è ampiamente sopra la media e riserva qualche passaggio davvero mozzafiato, il riffing è pregevole e l’esecuzione strumentale è ammirevole. Inoltre bisogna intercalarsi nella psicologia di chi suona: comporre un album musicale deve consistere necessariamente in una snervante ricerca di qualcosa di nuovo e originale? Oppure si possono comporre album musicali per puro divertimento? Io credo che questi quattro ragazzi russi siano dei fan sinceri degli Opeth e che di conseguenza trovino divertente ed eccitante imitare i loro inarrivabili idoli. Provate a proiettare su voi stessi la medesima situazione: non vi piacerebbe essere capaci di fare ciò che fanno le persone che più stimate? Non provereste soddisfazione nel realizzare di essere capaci di farle a vostra volta? Certo che sì. E poi in fondo per qualche nostalgico affezionato non è poi un male che ogni tanto spuntino band siffatte, visto che ultimamente gli Opeth - quelli veri - sembrano aver definitivamente abbandonato quel loro Progressive Death autunnale e paludoso che tanto li aveva resi celebri.
In definitiva io credo che ci siano cose ben più gravi da condannare che non le pacifiche scopiazzate, come ad esempio quelle band da quattro soldi quali Nightwish, Anathema, Amorphis ed altre che producono una musica così banale e commerciale che chiamarla musica è quasi un insulto, e lo fanno al solo fine della notorietà, dell’emancipazione dall’underground, dei dindi sonanti, svuotando così l’arte musicale di ogni significato artistico. Ecco, sono queste le band da stroncare brutalmente senza nemmeno il più piccolo briciolo di pietà, non certo gli appassionati musicisti come gli Alley che suonano quello che realmente gli appartiene, che gli scorre nelle vene, e che oltretutto in album come The Weed riescono a farlo in modo piacevole e convincente.
01 - Duhkha (04:44)
02 - Coldness (05:58)
03 - Dust Layer (09:11)
04 - Hessian Of Rime (07:21)
05 - Fading Fall (10:23)
06 - Jaded Mirrored (11:21)
07 - Days For Gray (14:35)