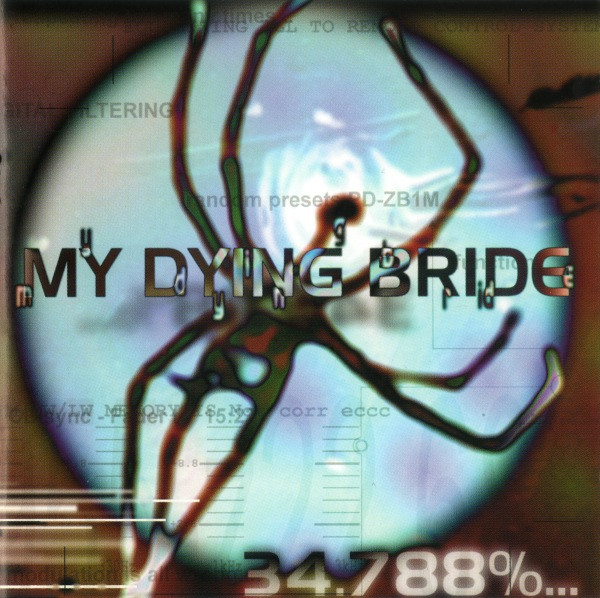|
| Napalm Records, 2012 |
Recensione scritta a quattro mani da Vanni e Daniele.
Un breve estratto dal diario di bordo della nave Nautik Funeral Doom, guidata dal comandante Ahab.
Giorno 1 (25/11/11): si salpa per il terzo emozionante viaggio nelle onde del burrascoso oceano Atlantico. Gli Ahab hanno annunciato che presto si dedicheranno alla registrazione del loro terzo disco, la scrittura del quale volge ormai al termine.
Giorno 68: gli Ahab sono in studio per le registrazioni, e quelle del basso e della batteria sono già state completate. I lavori sembrano procedere bene, ma il viaggio non è che all'inizio.
Giorno 98: ora il titolo del nuovo album è stato reso noto: "The Giant". Il disco sarà disponibile in maggio, quindi non prima di una sessantina di giorni. Ma la notizia più grandiosa è un trailer di quasi quattro minuti delle registrazioni dell’album! Lo splendido arpeggio che lo apre e la fragorosa musica in cui poi esplode accrescono la curiosità: gli Ahab stanno arrivando! Non vedo l’ora!
Giorno 103: oggi è stata una giornata strana, particolarmente provante. Gli Ahab hanno rivelato la copertina del loro nuovo full-length, che come primo impatto è molto deludente. L’idea è sicuramente carina, ma sembra mancare di serietà. Tuttavia dopo i primi istanti l’attenzione cade sul font usato per il titolo, e poi a catena su una serie di altri particolari: gli Ahab si sono dati alla psichedelia? No, mi sembra impossibile, è solo una stramba ipotesi.
Giorno 155: è il momento della svolta: finalmente un brano intero online! Si tratta della titletrack "The Giant". L’esperienza sonora è stata notevole ed emozionante! Il timbro degli Ahab lo si sente tutto, tanto nelle ritmiche quanto nello stile compositivo, ma ci sono grandi novità: le sonorità vanno in parte verso lo sludge, in parte verso il post metal, mentre alcuni riff suonano davvero psichedelici. La mia intuizione era sorprendentemente corretta! Uno sviluppo insperato da parte degli Ahab, ma sembra promettere molto bene.
Giorno 182: l'album esce nei negozi.
Giorno 252: acquisto l'album.
Giorno 253 (04/08/12): ascolto l'album.
Si preannunciava una rivoluzione pazzesca, sembrava delinearsi addirittura una svolta psichedelica. E invece tutto sommato "The Giant" è un album che non rinnega nulla di tutto quello che gli Ahab sono stati fino ad oggi: si “limita”, per così dire, ad introdurre una svolta più rockeggiante, orientata al post metal, con sonorità lievemente più scarne e minimali. Ma a conti fatti gli Ahab sono ancora gli Ahab: stessi ritmi, stesso songwriting, stesso feeling. Stesso funeral doom intelligente, elaborato sotto tutti i punti di vista (anche e soprattutto ritmicamente); stessa candida ossessione per le tematiche acquatiche e per tutto ciò che in musica richiama l'acqua e il suo ipnotico effetto. Ciò si riflette anche nell'aspetto tematico: così come "The Call Of The Wretched Sea" raccontava la storia della caccia a Moby Dick, e "The Divinity Of Oceans" narrava il dramma del naufragio della baleniera Essex, stavolta è Edgar Allan Poe ad essere tirato in ballo come ispirazione, rivisitando liberamente l'allucinata storia di Arhur Gordon Pym, marinaio di Nantucket che si imbarca clandestinamente su un vascello decretando l'inizio di una spaventosa spirale di orrore e morte. La cura e la maestria con cui gli Ahab effettuano questa trasposizione musicale è notevole, così come sono notevoli i testi, infarciti di vocaboli raffinati e particolari che li rendono dei veri e propri frammenti di grande letteratura. Così come succedeva con i precedenti due album, anche in questo caso è impossibile separare la musica dal testo: essi vanno di pari passo, e privati l'uno dell'altro sono come la mela di Platone, tristemente incompleta.
Musicalmente parlando, tutto ciò che rendeva gli Ahab una grande band è rimasto, è stato solo trasfigurato in una veste ancora più riflessiva, impalpabile, per certi versi sì psichedelica, ma non nel senso stretto del termine. "The Giant" non fa viaggiare con la mente, se non contestualmente alle atmosfere evocate; non è un trip che si potrebbe amplificare con una dose di droga sintetica. La psichedelia di "The Giant" è una psichedelia sommessa, più che altro un'attitudine per le sonorità liquide, inafferrabili, per le melodie enigmatiche e circolari, che dicono tutto e non dicono niente, così come il continuo sciabordio dell'acqua sulle rocce costiere racchiude in sè arcani significati che necessiterebbero di una vita intera per essere sviscerati. A dispetto della paludosa oscurità che continua a far parte del sound del gruppo, qui la componente melodica diventa ancora più forte che nei precedenti lavori, aiutata notevolmente da un uso incrementato del cantato pulito a discapito del sempre ottimo growl (il quale non perde nulla della sua catacombale efficacia). La voce maschile ammalia con momenti di assoluta bellezza come nell'opener "Further South", introdotta da chitarre gentili e pulite che suonano con tranquillità, mimando le prime onde del mattino che muovono delicatamente il vascello lasciato alla fonda. Nel momento in cui un cantato celestiale prende vita, una nuova emozione cresce dentro di noi: echi dei migliori Pink Floyd (a qualcuno è venuta in mente High Hopes?) fanno capolino, ma l'assoluta e indiscutibile personalità del quartetto tedesco fa sì che rimangano solo echi vaghi, mentre a fare tutto il lavoro è un connubio sopraffino di composizione, affinamento, arrangiamento e bilanciamento tra le parti. Tuttavia, gli Ahab non si sono dimenticati di ciò che sono, vale a dire un gruppo funeral doom metal; ecco che a metà brano compaiono riff schiaccianti, pesanti come macigni, dotati del consueto riverbero che anche stavolta ci fa sentire sperduti in mezzo all'oceano, se non addirittura in fondo ad esso. La maturità artistica raggiunta dal gruppo, anche solo dopo aver ascoltato questo primo brano, appare fin da subito impressionante.
"Aeons Elapse" comincia con un arpeggio inquietante, notturno; una voce sussurrante prepara l'esplosione di un riff apocalittico sostenuto da grida possenti, imperniate di sofferenza atroce, lamenti che ancora una volta ricordano l'angoscia di un naufragio, l'incessante agitarsi delle onde, ritmicamente diaboliche come solo l'acqua sa essere. Ma ecco che la nuova psichedelia Ahabiana fa capolino nella voce pulita e nelle scale arabe utilizzate per accompagnarla: sembra quasi di ascoltare la voce di un gigante delle acque, forse di Poseidone in persona, che si rivolge agli uomini con un tono divino e inappellabile. Una riff dalla potenza spaventosa distrugge la relativa beatitudine creata dal clean, mentre il growl acquista una forza espressiva che atterrisce; ma di nuovo, si ritorna su territori inesplorati e magici grazie ad una scala di chitarra costantemente ascendente e discendente, che sfuma lasciando solo i rintocchi di batteria, lenti e stanchi, a comunicarci un senso di incompiutezza. Un finale aperto. Che mai potrà succedere ancora, in questo viaggio maledetto e colmo di sventure?
"Deliverance (Shouting At The Dead)" sfrutta con eleganza le sue linee chitarristiche per creare atmosfere più serene e distensive, che riportano luce nei cuori nonostante la pesantezza dei suoni, e che curiosamente sono scelte per rappresentare uno dei momenti più drammatici della novella di Poe: l'incontro, dopo settimane alla deriva, di una nave il cui intero equipaggio è morto. Le melodie degli Ahab non sono mai state banali, anzi sono sempre state tra le melodie più raffinate ed eccellenti che ho mai ascoltato; se possibile, con quest'ultimo lavoro la band ha addirittura migliorato questa propria caratteristica, già di per sè eccelsa. All'arrivo della superba "Antarctica The Polymorphess", il quartetto tedesco ci mostra un volto ancora differente, il volto della malinconia, della bellezza sublime di un continente ghiacciato e candido che inizia ad apparire mentre si procede inesorabilmente verso sud; le parti in crescendo di stampo progressive sono a dir poco sbalorditive per l'efficacia con cui arrivano diritte al cuore senza nemmeno l'ombra di ruffianeria, così come è sbalorditiva la bellezza e l'eleganza delle parti melodiche, imperniate su una voce pulita dai toni elegiaci, celestiali. Dopo un finale tempestato di emozioni si prosegue il viaggio con la possente "Fathoms Deep Below", teatro di una lentezza pachidermica tipica del funeral doom più estremo; non capisco perchè questa traccia venga additatata come riempitiva e inferiore qualitativamente alle altre, dato che è un pezzo a mio parere superbo, sinistro e affascinante proprio come tutti gli altri brani di "The Giant". Vero, forse è quello che rimane meno stampato in testa, ma sarebbe un'assurdità dire che si poteva tranquillamente escluderlo dalla tracklist, come ho letto da qualche parte. Basta solo ascoltare l'eccellente assolo di chitarra, sempre giocato su scale misteriose che richiamano le profondità oceaniche ... Chiusa questa piccola parentesi, siamo arrivati a "The Giant", che conclude l'odissea con un incedere pesante, stentoreo, distruttivo: la lentezza diabolica del riff portante, che curiosamente non è affiancato ad un pesante growl ma ad un'allucinata voce in clean, atterrisce letteralmente chi l'ascolta. Un breve stacco a metà brano pare riportare la calma e la tranquillità, ma è solo l'inizio della fine: un lento e parossistico crescendo, l'ultimo, ci narra le ultime gesta di Arthur Gordon Pym, pronto a chiamare a sè questo sconosciuto e diafano gigante delle acque, che molte somiglianze ha con la morte. Sulle aggiunte presenti sulle edizioni limitate ("Time's Like Molten Lead" sulla versione digipak, e inoltre anche "Evening Star" sulla versione in vinile), non mi esprimo e lascio che siano gli ascoltatori a scoprirle piano piano: ogni epopea non è completa se non mantiene un certo mistero su almeno uno dei suoi aspetti.
Giorno 467. Ora che siamo giunti alla fine di questo emozionante terzo viaggio della nave Nautik Funeral Doom, guidata dal comandante Ahab, è con parole di assolute pienezza e soddisfazione che appongo il punto al diario di questo lungo, incredibile viaggio, un viaggio che mi ha lasciato dentro esperienze indelebili. Non posso essere sicuro che questi miei scritti si conserveranno con il passare del tempo, ma se qualcuno mai li leggerà, lo esorto ad intraprendere anche lui il viaggio dal quale sono tornato, e che mi ha arricchito come non mai, facendomi scoprire un mondo nuovo e meraviglioso. Non abbiate paura di salpare, la nave rolla e beccheggia ma vi condurrà sempre ad un porto sicuro, anche dopo la tempesta più violenta e paurosa ... sempre che non incontriate un vascello pieno di marinai morti sulla vostra strada.
01 - Further South (9:01)
02 - Aeons Elapse (12:48)
03 - Deliverance (Shouting At The Dead) (7:52)
04 - Antarctica The Polymorphess (11:49)
05 - Fathoms Deep Below (9:11)
06 - The Giant (10:39)