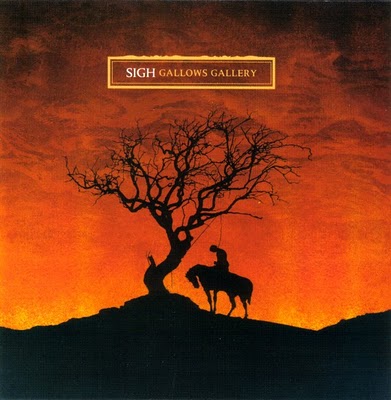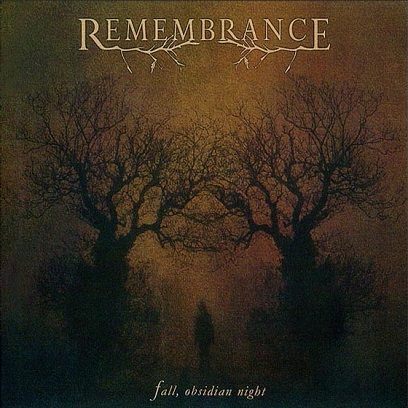|
| Furias Records, 2010 |
Dopo un debutto magistrale tornano infatti sulla scena gli argentini Fungoid Stream con il loro secondo album, registrato nell’estate del 2007 ma - per motivi a me oscuri - uscito soltanto nel 2010. Nonostante i testi siano ancora frammenti dell’opera di Lovercraft, l’artwork e il booklet ci parlano di un viaggio nell’apparente tranquillità delle profondità oceaniche, un mondo suggestivo popolato da strane creature che per i profani come me costituisce il punto di incontro tra i piani astrali e lo spazio. E così, dopo il turbinio di bolle susseguente l’immersione, scivoliamo lentamente nell’oscurità più profonda dell’oceano, galleggiamo in questa vastità sconosciuta, e una volta giunti sul fondale marino ci imbattiamo in splendide creature: troviamo una fauna dalla strumentazione minimale, che è un lento rincorrersi di placidi e solitari arpeggi, canti di balene e tastiere che paiono imitare la loro solitudine, cori sirenici di ogni genere e brulicanti narrazioni. E i fondali marini da noi raggiunti, suolo su cui si svolgono questi inseguimenti, sono sofficemente rivestiti da chitarre e voci soffuse mai invadenti. I Fungoid Stream confermano dunque tutto ciò che di buono avevano fatto sentire in Celaenus Fragments, compreso il loro immenso range di suoni al quale vengono dedicate un’attenzione ed una ricercatezza maniacali - nonostante il minimalismo strumentale. Ma Oceanus non è solo una conferma, bensì un passo avanti: l’idea che esso dà dei Fungoid Stream è quella di una band che ha fatto tesoro delle proprie ottime idee e ha raggiunto una maggior sapienza compositiva, riuscendo a non concentrarsi unicamente sulle atmosfere in tastiera che tanto li caratterizzava, ma a comporre brani completi e raffinati sorretti da buone strutture. I più eccellenti mi sembrano Antarktos e Night-Gaunts: entrambi sono apparentemente dei crescendo, ma entrambi risprofondano improvvisamente in una calma strumentale che porta con sé una tempesta emotiva, dipinta da arpeggi e tastiere che rimangono soli a tingere il silenzio. Splendida poi anche The Gardens Of Yin, coi suoi toni opprimenti, per non parlare dell’intro di Oceanus e Nemesis: nella prima aprono dei sintetizzatori fantastici che accompagnano un canto di balena, mentre la seconda si produce subito in un assolo melodico di chitarra degno dei migliori elogi.
Oceanus ruberà tre quarti d’ora scarsi della vostra vita per darvi in cambio un’ampia gamma cromatica di emozioni e un vassoio di momenti irripetibili tutti da assaporare. Oceanus, l’icona di una band che ha il grande merito di essere essenziale: usa sempre il minimo indispensabile che le occorre per ottenere il risultato desiderato, evitando di aggiungere strumenti che altrimenti si limiterebbero ad accompagnare - minimalismo che mette in risalto la loro abilità compositiva e le loro precise idee musicali. I Fungoid Stream rappresentano secondo la mia personalissima opinione quanto di più interessante c’è attualmente sulla scena Funeral Doom, insieme ad Ahab, Ea, Arcana Coelestia e Urna. L’unica pecca di questo disco è che poi finisce...
01 - Star-Winds (05:52)
02 - Antarktos (07:31)
03 - The Gardens of Yin (06:52)
04 - Interlude - The Pnakotic Manuscripts (02:21)
05 - Night-Gaunts (05:18)
06 - Oceanus (07:36)
07 - Nemesis (06:48)